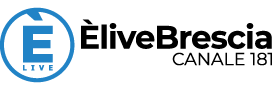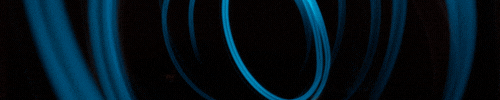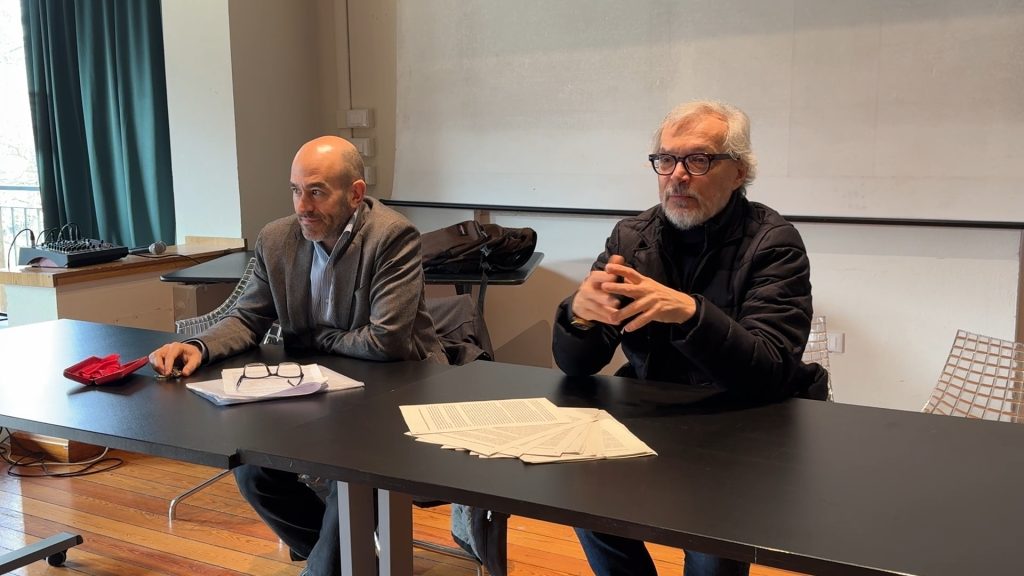
“Una stagione preoccupante per la tenuta della democrazia costituzionale in Italia”, è il documento che 29 docenti dell’Università di Brescia (su un totale di 62) hanno firmato per richiamare l’attenzione dei cittadini sull’azione dell’attuale Maggioranza.
Dal clima di scontro con la Magistratura, sempre più caldo, al Ddl Sicurezza con il ruolo dei Servizi Segreti nelle Università e la punibilità della “protesta con la resistenza passiva” tanto in carcere quanto in occasione di manifestazioni. “Vengono messi in discussione i principi costituzionali che insegniamo ogni giorno in Università” dicono i promotori dell’iniziativa.
“Il Ddl sicurezza mette in atto misure violentemente repressive del dissenso ma la democrazia vive di conflitti e demonizzare il conflitto è preoccupante. Quello che vediamo – aggiunge Luca Masera, avvocato penalista – è l’inizio di un percorso autoritario e la nostra responsabilità e rendere edotti i cittadini di questo pericolo”.
Un’azione che, oltre ad documento sottoscritto da 29 docenti dell’Unibs, si tradurrà in una serie di incontri aperti alla cittadinanza che avranno il compito di fornire le “competenze tecniche” necessarie alla valutazione del provvedimento del Governo. Un lavoro propedeutico ad un eventuale referendum abrogativo nel caso il Ddl diventasse legge con queste prescrizioni.
IL DOCUMENTO IN SINTESI
“Ci riferiamo in particolare a due provvedimenti in discussione alle Camere” – scrivono i docenti UniBs – “che rischiano di innescare una pericolosa involuzione autoritaria del nostro ordinamento giuridico. Il primo è quello relativo alla riforma della giustizia e alla separazione della carriere; il secondo è il cd. ddl sicurezza”.
“Da un lato, con le continue aggressioni mediatiche ai magistrati che assumono decisioni non gradite e con il progetto di separazione delle carriere, che mira a disgregare l’unità della magistratura ordinaria (in realtà ci si preoccupa solo della giustizia penale), si vuole polemicamente e primariamente punire la magistratura inquirente, impedendole di esercitare un controllo di legalità a tutto campo; dall’altro lato, con le norme che reprimono il dissenso, si vogliono intimorire coloro che si oppongono a tali misure, rafforzando come mai prima nella storia della Repubblica gli strumenti repressivi dei movimenti di protesta”.
“La Storia (anche quella meno risalente) – sottolineano i 29 docenti – ci insegna che è proprio a partire dal contrasto alla magistratura e alla libera espressione del dissenso che prendono avvio le svolte in senso autoritario. Come cittadini/e, ma soprattutto come giuristi/e che incrociano e formano studenti/esse universitari/e, sentiamo il dovere di segnalare all’opinione pubblica la gravità del progetto che sta iniziando a prendere consistenza e di mettere le nostre competenze tecniche a disposizione delle associazioni e dei movimenti che intendano opporsi, innanzitutto sul piano culturale, a questa dilagante regressione giuridica, restando sempre disponibili a ragionare nel merito delle proposte avanzate da qualsiasi parte politica, ma anche saldamente ancorati al costituzionalismo democratico occidentale e alle sue conquiste culturali, che è nostro dovere non rinnegare né per moda né per paura di dispiacere il contingente potere politico”.
L’AVVOCATO LUCA MASERA A ÈLIVE
IL DOCUMENTO INTEGRALE E I FIRMATARI
“Come docenti di materie giuridiche in un’Università pubblica, riteniamo doveroso, sul piano etico e professionale, evidenziare alcuni tratti dell’azione dell’attuale maggioranza governativa che consideriamo allarmanti e potenzialmente lesivi della tenuta dell’ordinamento democratico delineato dalla nostra Costituzione. Ci riferiamo in particolare a due provvedimenti in discussione alle Camere che, se approvati nell’attuale formulazione, rischiano di innescare una pericolosa involuzione autoritaria del nostro ordinamento giuridico.
Il primo testo su cui desideriamo richiamare l’attenzione è il disegno di legge costituzionale in materia di giustizia e di separazione delle carriere dei magistrati. A prescindere dal merito della riforma – che presenta numerosi profili critici che qui non possiamo esaminare in dettaglio – l’aspetto più preoccupante è il contesto in cui questa proposta si inserisce e l’obiettivo ultimo che persegue, come dichiarato apertamente dal Ministro della Giustizia (il Guardasigilli), dalla Presidente del Consiglio, e da autorevoli esponenti dell’area di governo.
Da mesi, infatti, assistiamo ad attacchi quotidiani nei confronti di magistrati che emettono decisioni non in linea con le aspettative della maggioranza politica. L’ambito dell’immigrazione – in particolare la gestione degli arrivi via mare e i centri di detenzione aperti in Albania – è emblematico: di fronte a provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi, la prassi consolidata consiste nell’attacco personale ai giudici, subito etichettati come “politicizzati”, tacciati di voler ostacolare la maggioranza dal realizzare appieno il proprio “vittorioso” progetto elettorale, che viene esaltato come indiscutibile mandato popolare, secondo una visione regressiva della democrazia e della rappresentanza parlamentare. Negli ultimi giorni, l’attacco alla giurisdizione ha perfino oltrepassato i confini nazionali, arrivando a coinvolgere la Corte penale internazionale (CPI). Il Ministro della Giustizia, di fronte all’iniziativa di espellere dal nostro Paese il membro di una milizia (sostenuta dal governo libico) sospettato di crimini contro l’umanità, ha difeso il proprio operato accusando la Corte di presunte violazioni procedurali. Il vero problema, però, non sta nella denuncia di possibili irregolarità, bensì nel fatto che il Ministro delegittimi la Corte e la sua funzione, pretendendo di sostituire il proprio giudizio a quello dell’autorità competente. Questo atteggiamento è emerso in modo evidente anche nell’intervento ufficiale al Senato, dove il Guardasigilli ha rivendicato un potere di valutazione nel merito delle decisioni della CPI, del tutto sprovvisto di fondamento normativo.
La premessa culturale dell’indirizzo politico che si intende perseguire appare molto chiara: si vuole far credere all’opinione pubblica che il controllo di legalità operato dalla magistratura rappresenti un improprio ostacolo alla realizzazione dei progetti promossi dalla maggioranza uscita vincitrice dalle elezioni. In questa prospettiva, i/le magistrati/e vengono accusati/e di promuovere un proprio contro-obiettivo politico tutte le volte che ritengono illegittimo un provvedimento di derivazione politico-parlamentare, anziché limitarsi alla sua applicazione pedissequa. In questo schema argomentativo, piuttosto rozzo e semplificato, spariscono del tutto i previsti poteri di garanzia affidati alla Corte costituzionale alla quale invece i/le giudici, prima di applicarle, devono sottoporre le leggi che reputino in contrasto con la Costituzione. Analogamente si ignora – clamorosamente – l’ormai acquisita prevalenza, stabilita sul terreno costituzionale, del diritto europeo e internazionale sul diritto interno, che pacificamente non può trovare applicazione in sede giurisdizionale laddove contraddica norme di rango sovranazionale.
Ecco perché appare paradossale e distorsivo evocare la separazione delle carriere dei magistrati ordinari addirittura come salvifico correttivo dell’ordinamento, ogniqualvolta un/a magistrato/a assuma una decisione sgradita agli esponenti di governo: così connotando di un chiaro intento punitivo la riforma costituzionale, che viene presentata come la soluzione ad una patologica ingerenza di una parte influente della magistratura nel campo della politica. In qualità di studiosi/e di discipline giuridiche, un tale disegno ci appare in tutta la sua chiara pretestuosità e ci sembra pericoloso poiché in grado di veicolare, camuffandola, una oramai superata visione ottocentesca e pre-costituzionale dei rapporti tra poteri dello Stato, nella quale l’attività legislativa e, in generale, la regolamentazione della societas è concepita come libera da vincoli sovraordinati, segnatamente di natura costituzionale. E invece l’elemento essenziale degli ordinamenti democratici moderni è proprio quello di garantire, attraverso norme costituzionali rigide, la separazione del controllo giurisdizionale dall’esercizio del potere politico, al fine di meglio favorire, in concreto, il rispetto dei diritti fondamentali della persona che non sono più nella disponibilità di chi, pur legittimamente, detiene lo “scettro del comando”.
Il secondo provvedimento che reputiamo incompatibile con i principi di uno Stato costituzionale di diritto è il cd. disegno di legge Sicurezza, già approvato in prima lettura al Senato. Anche in questo caso non abbiamo qui lo spazio per entrare nel merito delle singole misure proposte, che hanno come cifra identificativa l’inasprimento degli strumenti di repressione del dissenso, sino al punto di arrivare a punire con la sanzione penale forme di protesta non violenta, come i blocchi stradali, o addirittura la resistenza passiva, nei casi di proteste all’interno delle carceri o dei luoghi di detenzione per stranieri. Per quanto poi riguarda direttamente il mondo dell’Università, desta gravissima preoccupazione il disposto dell’art. 31 del d.d.l, secondo cui i servizi di informazione, a tutela della “sicurezza nazionale” , potranno chiedere informazioni sulle attività di studenti e docenti, in deroga alla normativa a tutela della privacy e della protezione dei dati sensibili.
Da un lato, quindi, con le continue aggressioni mediatiche ai magistrati che assumono decisioni non gradite e con il progetto di separazione delle carriere, che mira a disgregare l’unità della magistratura ordinaria (in realtà ci si preoccupa solo della giustizia penale), si vuole polemicamente e primariamente punire la magistratura inquirente, impedendole di esercitare un controllo di legalità a tutto campo, inclusa la verifica sulla possibile commissione di reati ministeriali da parte degli esponenti del Governo; dall’altro lato, con le norme che reprimono il dissenso, si vogliono intimorire coloro che si oppongono a tali misure, rafforzando come mai prima nella storia della Repubblica gli strumenti repressivi dei movimenti di protesta.
La Storia (anche quella meno risalente) ci insegna che è proprio a partire dal contrasto alla magistratura e alla libera espressione del dissenso che prendono avvio le svolte in senso autoritario. Come cittadini/e, ma soprattutto come giuristi/e che incrociano e formano studenti/esse universitari/e, sentiamo il dovere di segnalare all’opinione pubblica la gravità del progetto che sta iniziando a prendere consistenza e di mettere le nostre competenze tecniche a disposizione delle associazioni e dei movimenti che intendano opporsi, innanzitutto sul piano culturale, a questa dilagante regressione giuridica, restando sempre disponibili a ragionare nel merito delle proposte avanzate da qualsiasi parte politica, ma anche saldamente ancorati al costituzionalismo democratico occidentale e alle sue conquiste culturali, che è nostro dovere non rinnegare né per moda né per paura di dispiacere il contingente potere politico.
Un gruppo di docenti di materie giuridiche dell’Università di Brescia (29 firmatari su 62)
Proff.
Antonio D’Andrea, diritto costituzionale
Luca Masera, diritto penale
Cristina Alessi, diritto del lavoro
Adriana Apostoli, diritto costituzionale
Rosanna Breda, diritto privato
Margherita Brunori, diritto agrario
Arianna Carminati, diritto costituzionale
Daniele Casanova, diritto costituzionale
Chiara Di Stasio, diritto internazionale
Matteo Frau, diritto pubblico comparato
Elisabetta Fusar Poli, storia del diritto Mario Gorlani, diritto costituzionale
Massimiliano Granieri, diritto privato comparato
Giulio Itzcovich, filosofia del diritto
Stefano Liva, diritto romano
Nadia Maccabiani, diritto costituzionale
Francesca Malzani, diritto del lavoro
Loredana Mura, diritto internazionale
Federica Paletti, storia del diritto
Paola Parolari, filosofia del diritto
Luca Passanante, diritto processuale civile
Andrea Perin, diritto penale
Marco Podetta, diritto costituzionale
Susanna Pozzolo, filosofia del diritto
Luisa Ravagnani, criminologia
Fabio Ravelli, diritto del lavoro
Carlo Alberto Romano, criminologia
Giovanni Turelli, diritto romano
Laura Zoboli, diritto commerciale